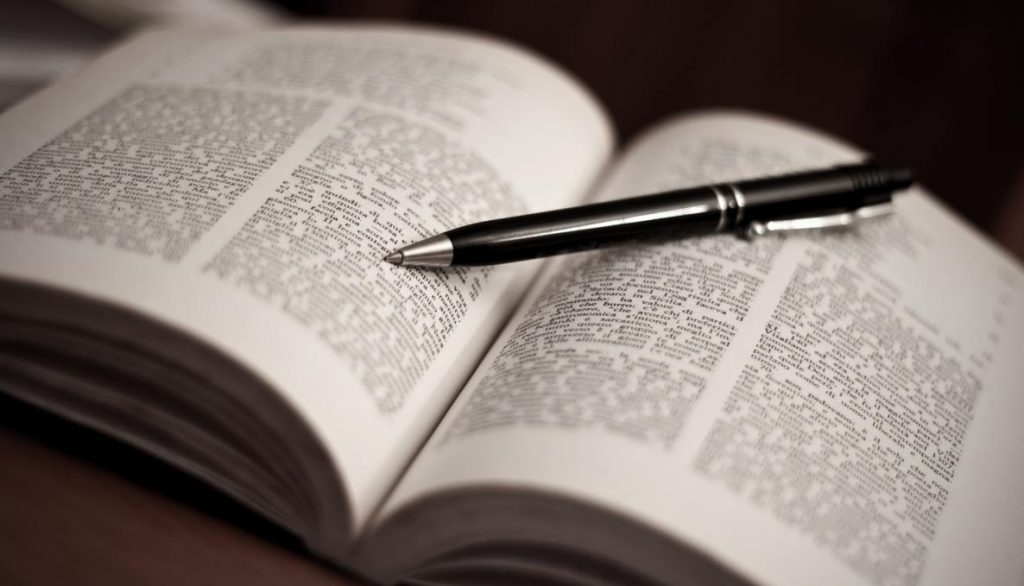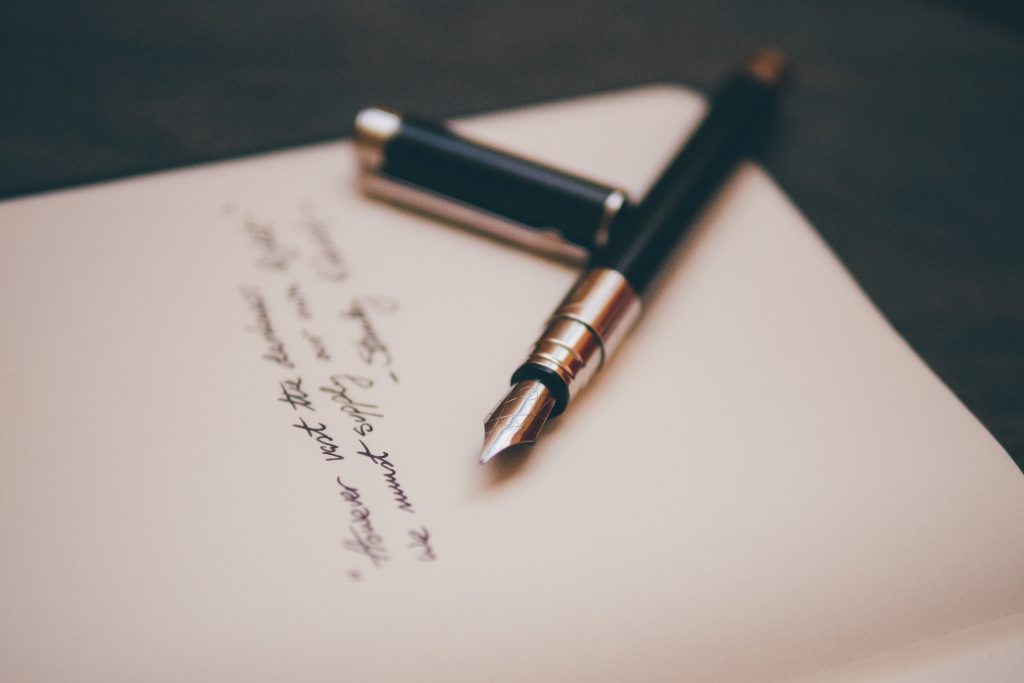1. ASPETTI GENERALI
1.1 I principi di chiarezza e sinteticità degli atti
La riforma della giustizia, cd. Riforma Cartabia, la cui parte più significativa entrerà in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023, ha ridisegnato lo schema del processo civile, in particolare del giudizio di primo grado, mediante la riformulazione di tempi e modalità di svolgimento del processo, nonché con l’introduzione di un rito “semplificato”, che si affianca al rito ordinario in determinate ipotesi tassativamente previste.
Importanti modifiche hanno interessato anche la parte dei principi generali del processo, tra i quali occorre, in primo luogo, segnalare, l’introduzione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del Giudice e delle parti, che per la prima volta sono stati introdotti nell’ordinamento processuale civile, in un’ottica di accelerazione del processo.
Ed infatti, a tal fine è stato modificato l’art. 121 c.p.c., sia nella rubrica, sia nel testo, aggiungendo alla rubrica originaria, dedicata ad affermare il principio della libertà delle forme, il principio della chiarezza e sinteticità degli atti; mentre, al primo comma della norma in parola è stata aggiunta una ulteriore frase, nella quale si specifica che tutti gli atti, quindi non solo quelli di parte, ma anche quelli del Giudice, devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.
Su punto occorre segnalare come il Legislatore, pur valutando l’importanza e la necessità di codificare i principi della chiarezza e della sinteticità degli atti, non sembra, tuttavia, aver previsto alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto di tali principi, né sembra aver fornito al Giudice uno specifico strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici.
È previsto, infatti, che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comportano l’invalidità, ma possono essere valutati dal Giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Sembra opportuno, quindi, distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità, riconoscendo una loro autonomia: la chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure; la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.
Pertanto, in realtà, la mancanza di chiarezza dell’atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi.
La mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica.
1.2 I doveri di collaborazione delle parti e dei terzi
Sempre sul piano dei principi generali, sono state introdotte una serie di modifiche volte a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi.
Più in particolare, in primis, è stato modificato l’art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità aggravata, aggiungendo un quarto comma, con il quale è stato previsto che, nei casi disciplinati dai commi precedenti, il Giudice può comminare alla parte soccombente la sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Con la medesima finalità di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono stati, poi, parzialmente modificati anche gli artt. 118 e 210 c.p.c., mediante l’inserimento della previsione di conseguenze processuali e di sanzioni pecuniarie (v. sopra) nei casi di rifiuto ingiustificato di eseguire un ordine di ispezione o cose comminato dal giudice nel corso dell’istruttoria e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati di consentire l’ordine di esibizione.
La sanzione non è tuttavia automatica, consentendo sempre al Giudice di valutare se l’inadempimento risulti giustificato.
Infine, si è introdotta una conseguenza piuttosto pregiudizievole, nei casi disciplinati dall’art. 210 c.p.c., sempre nell’ipotesi di ingiustificato rifiuto di adempimento dell’ordine di esibizione, nel qual caso è stato previsto che il Giudice potrà desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
1.3 La nuova disciplina delle udienze
Tra le modifiche di maggiore rilevanza, rientra sicuramente la previsione relativa alla “stabilizzazione” delle udienze telematiche a distanza e delle udienze cartolari, introdotte nel nostro ordinamento processuale in occasione dell’emergenza pandemica.
Più in particolare, il nuovo terzo comma dell’art. 127 c.p.c., rubricato “Direzione dell’udienza”, detta una disposizione di principio, in base alla quale il Giudice può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o che sia sostituita dal deposito di note scritte, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 127 bis e 127 ter c.p.c., che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’udienza in presenza.
Ed invero, l’art. 127 bis c.p.c., rubricato “Udienza mediante collegamenti audiovisivi”, prevede al primo comma che lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal Giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il secondo comma, analogamente a quanto previsto per l’udienza cartolare, regolamenta i termini di comunicazione del provvedimento del giudice e l’esercizio della facoltà di opposizione delle parti.
Al fine di dare attuazione a tale facoltà di opposizione, infatti, è stato previsto che il provvedimento con cui il giudice dispone lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza sia comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza e che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, possa chiedere che l’udienza si svolga in presenza.
Il Giudice, a fronte di tale istanza, è tenuto a provvedere nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.
Allo stesso modo, il Legislatore ha introdotto l’art. 127 ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”, che innanzitutto, al primo comma, prevede che l’udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Aggiunge, poi, che, negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
Nei successivi commi è disciplinato il procedimento con cui il giudice dispone lo scambio delle note scritte che sostituiscono l’udienza, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze che ne derivano.
In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il Giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile (analogamente a quanto disposto dall’articolo 127 bis c.p.c.) e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.
Assegnato il termine per lo scambio delle note scritte, il Giudice deve, quindi, provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del predetto.
Nel caso in cui che nessuna delle parti depositi le note nel termine concesso, il Giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa l’udienza; se alcuna delle parti, nuovamente, non deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, con meccanismo analogo a quello previsto, in caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive, dagli artt. 181 e 309 c.p.c.
È da segnalare, infine, come il Legislatore abbia precisato che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note è considerato data di udienza, ricollegandovi quindi tutti gli effetti ad essa conseguenti.
1.4 Le modifiche alla disciplina in tema di notificazioni
Di sicuro rilievo sono senz’altro le novità introdotte dalla Riforma in materia di notifiche e relative all’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005.
Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
Se la notificazione è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l’avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 359) e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
Se, invece, la causa non è imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.
Al fine di coordinare le novità introdotte dalla Riforma con la disciplina codicistica è stato modificato l’art. 137 c.p.c., mediante l’aggiunta del sesto e del settimo comma.
Al riguardo, il sesto comma stabilisce che l’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge, dando atto così della disciplina contenuta nella l. n. 53 del 1994, dedicata alle notificazioni effettuate direttamente dall’avvocato.
Il settimo comma, invece, si è reso necessario per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica, stabilendo che l’Ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con diversa modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.
Ulteriori modifiche sono state apportate, altresì, all’art. 139 c.p.c., il cui quarto comma è stato sostituito dal seguente: «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata».
La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l’ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell’attività svolta, con valore probatorio dell’atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà certificatoria che l’ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali.
Infine, è stato modificato l’art. 149 bis c.p.c., disponendo la notifica via pec anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario.
2. LE MODIFICHE RELATIVA AL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE
2.1 La fase introduttiva di giudizio
Le più importanti novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia riguardano sicuramente la fase introduttiva del giudizio civile di primo grado dinanzi al Tribunale.
Ed infatti, la Riforma ha disposto una inversione rispetto all’attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all’udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell’udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.
A tal fine, in primo luogo, sono stati modificati gli artt. 163, comma n. 3 e n. 4, e 167, comma 1, c.p.c.
Più in particolare, la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità ha comportato l’inserimento della locuzione «in modo chiaro e specifico» laddove viene disciplinato il contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta.
Successivamente, è stato modificato il n. 7) dell’art. 163, comma 3, c.p.c., mediante l’aggiunta di un nuovo avvertimento che l’atto di citazione dovrà necessariamente riportare nella vocatio in ius, e segnatamente: «che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Inoltre, al fine di coordinare il nuovo impianto processuale, il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell’udienza, al fine di consentire lo scambio delle memorie scritte antecedentemente all’udienza di prima comparizione.
Sempre con l’intento di coordinamento e con l’obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo, è stato aggiunto un ulteriore requisito dell’atto di citazione, al punto 3 bis, consistente nell’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.
La necessità di rimodulare tutti i termini processuali della fase introduttiva ha reso necessaria la modifica dell’art. 163 bis c.p.c., con l’estensione del termine a comparire a centoventi giorni.
Il termine di settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione diventa, dunque, il nuovo termine per le preclusioni e decadenze ex art. 167 c.p.c.
2.2 Le verifiche preliminari ad opera del Giudice
Con il nuovo sistema, in cui la definizione del thema decidendum e del thema probandum deve avvenire in una fase antecedente all’udienza di prima comparizione, mediante lo scambio di memorie scritte da depositarsi entro termini da calcolarsi a ritroso da essa, si è reso necessario prevedere un meccanismo che consenta al Giudice di effettuare tutte le verifiche preliminari prima ancora che inizino a decorre i termini suddetti.
Pertanto, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il Giudice è tenuto a compiere tutte le verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio, quali, in particolare: (i) la verifica della sua rituale instaurazione e della sua integrità qualora si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario; (ii) della chiamata in causa di terzi; (iii) della nullità degli atti introduttivi; (iv) di difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione; (v) della sussistenza di condizioni di procedibilità ovvero di ulteriori questioni rilevabili d’ufficio da indicare alle parti, di cui ritiene opportuna la trattazione.
All’esito di tali verifiche, qualora il Giudice debba effettuare rilievi ed assumere provvedimenti in ordine a tali profili, gli stessi sono poi trattati dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 ter c.p.c.
Qualora vengano assunti provvedimenti, il Giudice, se necessario, fissa una nuova udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall’art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso, poi, è stata prevista la facoltà per il Giudice, anche qualora non provveda ai sensi del secondo comma, di differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza.
Quanto ai controlli, tuttavia, appare opportuno evidenziare l’inserimento di due verifiche nuove: la prima, relativa alle condizioni di procedibilità della domanda e, la seconda, relativa alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.
In questi casi, è previsto che il giudice debba indicare le questioni alle parti, sollecitando il contraddittorio al riguardo, nell’ambito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Tra le verifiche preliminari che il Giudice è tenuto ad effettuare, vi è anche la verifica della regolarità della procura al difensore, al fine di rilevare eventuali difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.
Altra modifica attiene al secondo comma dell’art. 182 c.p.c., che ha opportunamente chiarito che il termine per la sanatoria va assegnato dal Giudice anche in caso di totale mancanza della procura al difensore.
2.3 La delimitazione del thema decidendum e del thema probandum
Come già si è avuto modo di anticipare, per fare in modo che si giunga all’udienza di prima comparizione successivamente alla completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, è stata invertita la attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all’udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell’udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.
A tal fine, il legislatore delegato ha inserito l’art. 171 ter c.p.c., volto a disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell’udienza.
Pertanto, con le memorie integrative, le parti possono, a pena di decadenza:
1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Le tre memorie integrative coincidono, nella sostanza, con quelle attualmente contemplate dall’art. 183, comma 6, c.p.c., ma devono essere depositate anteriormente alla prima udienza.
2.4 La nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c.
Con le modifiche apportate dalla riforma, l’udienza di prima comparizione acquisisce un ruolo centrale, essendo delineata come il momento in cui il Giudice già si trova nelle condizioni per valutare se si necessiti di un’attività istruttoria, ovvero se la causa sia già matura per la decisione
Innanzitutto, è stato introdotto in via generale per il rito ordinario il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per questo motivo, viene stabilito che le parti debbano comparire personalmente nella prima udienza e che la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sia valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Poi, il terzo comma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e chieda i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati, procedendo poi al tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell’art. 185 c.p.c., il cui richiamo espresso consente alle parti, ove lo ritengano, di farsi rappresentare per tale adempimento.
Il quarto comma prevede che, alla stessa udienza, il Giudice provveda sulle istanze istruttorie, predisponendo il calendario del processo e fissando l’udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni.
All’esito della prima udienza, poi, è prevista la facoltà per il Giudice di riservare la decisione sui mezzi di prova, emettendo la relativa ordinanza entro i successivi trenta giorni.
Infine, qualora vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal Giudice, i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal Giudice.
2.5 La fase decisoria
Analogamente alla fase introduttiva, anche in riferimento alla fase decisoria la Riforma in esame ha attuato un ribaltamento dei termini per il deposito delle memorie conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione.
Tale importante modifica ha reso necessaria innanzitutto la soppressione dell’art. 190 c.p.c., che prevedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica successive alla precisazione delle conclusioni.
Quindi, si è intervenuti sugli artt. 189 e 275 c.p.c., per le cause di competenza collegiale, e sull’art. 281 quinquies c.p.c., per le cause di competenza monocratica.
In entrambi i casi, il nuovo modulo decisorio prevede che venga fissata un’udienza, detta di rimessione della causa al Collegio ovvero di rimessione della causa in decisione, rispetto alla quale decorrono, a ritroso, tre termini, rispettivamente: (i) per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima); (ii) per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima); infine, (iii) per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima).
Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti e, in tal caso, il Giudice può trattenere la causa immediatamente in decisione.
Nel nuovo sistema il termine per il deposito della sentenza (rimasto invariato nella misura di 60 giorni per le cause di competenza collegiale e di 30 giorni per quelle monocratiche) non decorre più dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica delle parti, bensì, atteso il meccanismo dei termini a ritroso, dall’udienza di rimessione della causa al collegio, ovvero in decisione.
Inoltre, gli artt. 275 e 281 quinquies c.p.c. riservano, comunque, alla parte la possibilità di chiedere che la causa venga discussa oralmente, disciplinando moduli decisori di tipo misto, con discussione in parte scritta ed in parte orale.
In conclusione, all’esito degli interventi del legislatore delegato, possono quindi delinearsi vari moduli decisori, che sono sostanzialmente speculari per le cause di competenza collegiale e per quelle di competenza monocratica.
Lo schema ordinario è quello a trattazione scritta, in cui il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l’udienza per la rimessione in decisione (o al collegio) ed assegna alle parti tre termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali; 3) fino quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
In alternativa, può adottarsi uno schema decisorio a trattazione mista, ma in tal caso è sempre necessaria l’istanza di parte e non può essere disposto d’ufficio. Tale schema prevede la fissazione dell’udienza per la discussione orale e per la rimessione della causa in decisione, nonché l’assegnazione di soli due termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima dell’udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) fino a trenta giorni prima dell’udienza, per il deposito delle comparse conclusionali.
Infine, può adottarsi lo schema decisorio della trattazione esclusivamente orale, in cui il Giudice, anche d’ufficio, invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l’udienza per la discussione orale della causa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, e decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata nel verbale e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In alternativa, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l’udienza per la discussione orale, all’esito della quale trattiene la causa in decisione.
Più articolato è lo schema di decisione a trattazione orale delle cause di competenza collegiale, perché in tal caso è prevista comunque l’assegnazione di un termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine per le memorie conclusionali.
Ciò che caratterizza questo schema decisorio è che, all’esito della discussione, il collegio pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e la sentenza si considera pubblicata con la sottoscrizione, da parte del Presidente, del verbale che la contiene.
3. IL NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE
La Riforma in esame, sulla falsariga del procedimento disciplinato dall’art. 702 bis e s.s. c.p.c., ha introdotto nel Libro II, il nuovo «procedimento semplificato di cognizione».
Tale procedimento si caratterizza per l’essere pienamente alternativo a quello ordinario, in quanto a cognizione piena, ma sommario e deformalizzato solo per quanto riguarda l’istruttoria e l’iter procedimentale.
Al fine di disciplinare tale nuovo istituto, il legislatore delegato ha, innanzitutto, inserito un primo articolo, l’art. 281 decies c.p.c., volto a definire l’ambito di applicazione del rito semplificato.
Il primo comma di tale norma, infatti, indica quali caratteristiche devono avere le cause per essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato, facendo riferimento a quattro alternativi presupposti: (i) quando i fatti di causa non sono controversi; (ii) quando la domanda è fondata su prova documentale; (iii) o è di pronta soluzione; ovvero (iv) richiede un’istruzione non complessa.
Il secondo comma prevede, poi, che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Il successivo art. 281 undecies c.p.c. disciplina, invece, la forma della domanda e la costituzione delle parti.
A tal fine, il primo comma prevede che la comanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163 c.p.c.
Il secondo comma disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell’udienza con decreto del Giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto, e si prevede, a garanzia del diritto di difesa, che il termine minimo a comparire per il convenuto sia di quaranta giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.
Il terzo e il quarto comma disciplinano le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata di un terzo in causa, prevedendo a tal fine che il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.
A pena di decadenza, inoltre, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Infine, ai sensi del quarto comma, se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il Giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.
Restano, invece, invariati il termine per la costituzione del convenuto (non oltre dieci giorni prima dell’udienza) ed il termine che deve intercorrere tra la notificazione del ricorso e l’udienza di comparizione (quaranta giorni), con riferimento al quale si precisa che deve trattarsi di termine libero.
Avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e fissata l’udienza di comparizione delle parti, il procedimento successivo è disciplinato dall’art. 281 duodecies c.p.c., il cui primo comma prevede che all’udienza il Giudice proceda alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il rito semplificato, di cui all’art. 281 decies, comma 1, c.p.c., eventualmente disponendo il mutamento del rito nelle forme ordinarie. Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi in cui, trattandosi di controversia di competenza del Tribunale in composizione monocratica, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia.
In caso di mutamento del rito da semplificato a ordinario il Giudice è tenuto a fissare l’udienza ex art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono, ex lege, i termini per le memorie integrative di cui all’art. 171 ter c.p.c.
Il secondo comma disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario.
Il terzo comma disciplina le facoltà che le parti possono esercitare a pena di decadenza all’udienza.
Il quarto comma prevede che le parti possano chiedere l’assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il Giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l’assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma, e comunque ridotti rispetto a quelli ordinari.
Il quinto comma prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.
Il mutamento del rito in ordinario deve essere disposto nella prima udienza, al verificarsi di due ipotesi: 1) quando non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 281 decies, comma 1, c.p.c.; 2) quando la lite e l’istruzione probatoria si presenti complessa.
Qualora venga disposto il mutamento del rito, le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo, considerato che nulla viene previsto al riguardo dall’art. 281 duodecies c.p.c.
Il nuovo rito semplificato sembrerebbe incompatibile con il rito lavoro e locatizio, tenuto conto anche del diverso regime delle preclusioni.
La disciplina del nuovo rito semplificato, invece, prevede che, alla prima udienza, le parti possano, a pena di decadenza, proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Sempre nella prima udienza, le parti possono anche chiedere al Giudice, se sussiste un giustificato motivo, un primo termine perentorio non superiore a venti giorni, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni, per replicare e dedurre prova contraria.
Di regola, quindi, le parti hanno l’onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie, poiché il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo.
Infine, la fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall’art. 281 terdecies c.p.c., prevedendo che il rito si concluda con sentenza, applicando il modulo decisorio di cui all’art. 281 sexies c.p.c., per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, e quello previsto dall’art. 275 bis c.p.c., per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Il secondo comma, poi, stabilisce semplicemente che la sentenza è impugnabile secondo i modi ordinari.
L’introduzione del nuovo rito semplificato ha reso necessaria la modifica dell’art. 183 bis c.p.c., che disciplinava il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. È stato, quindi, previsto che all’udienza di trattazione il Giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281 decies c.p.c., dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell’art. 281 duodecies c.p.c., ovvero le disposizioni compatibili con tale passaggio.
4. LE NOVITÀ RELATIVE AL RITO DEL LAVORO
La Riforma in esame, benvero, non interviene in maniera significativa in riferimento al rito del lavoro, introducendo tuttavia alcune novità sicuramente degne di nota, ovvero: (i) l’introduzione della negoziazione assistita e (ii) la previsione del nuovo art. 441 bis per le controversie in materia di licenziamenti.
4.1 La negoziazione assistita in materia di lavoro
In riferimento alla prima novità sopra segnalata, è stato modificato il D.L. n. 132 del 2014, mediante l’introduzione dell’art. 2 ter, il quale prevede che per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 ter c.p.c., le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.
All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, c.c.
Il rinvio operato all’art. 2113, comma 4, c.c., induce a ritenere che l’intervento degli avvocati sia stato equiparato a quello del Giudice, dell’autorità amministrativa e dell’associazione di categoria, sicché l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione sarà assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo dell’art. 2113 c.c. – dell’impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l’intervento degli avvocati – terzi investiti di una funzione pubblica – è stato ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore, precludendo l’impugnabilità dell’accordo raggiunto.
4.2 Introduzione dell’art. 441 bis e ss. nel codice di procedura civile
La seconda importante novità in materia di rito del lavoro, riguarda l’introduzione, nel nuovo Capo I bis “Delle controversie relative ai licenziamenti” del Titolo IV, dell’art. 441 bis, il quale trova applicazione in tutti i casi in cui, con l’impugnazione di un atto di licenziamento, venga richiesta la reintegrzione nel posto di lavoro.
Il testo dell’art. 441 bis, in particolare, prevede ora che «la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il Giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.
All’udienza di discussione il Giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il Giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione».
Nonostante l’abrogazione delle norme relative al c.d. rito Fornero, viene ribadita, dunque, la finalità di procedere ad una definizione rapida delle controversie al cui esito può essere ripristinato il rapporto di lavoro.
Rispetto al passato, tuttavia, il Legislatore non ha introdotto riti alternativi, ma ha semplificato la disciplina vigente ripristinando l’unicità del rito, cosicché tutte le controversie in materia di licenziamento saranno, a decorrere dall’entrata in vigore della Riforma, assoggettate alla disciplina di cui gli artt. 409 ss. c.p.c., con conseguente abrogazione dello speciale procedimento di cui alla legge n. 92 del 2012.
Nei casi in esame, pertanto, il rito del lavoro non viene sostanzialmente modificato, consentendo, tuttavia, al Giudice di ridurre i tempi del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso e prevedendo un termine congruo, comunque non minore di 20 giorni, fra la data di notificazione del ricorso e l’udienza di discussione, lasciando al Giudice tanto la possibilità di esercitare d’ufficio questo potere, quanto una certa discrezionalità nell’an e nel quomodo del suo esercizio.