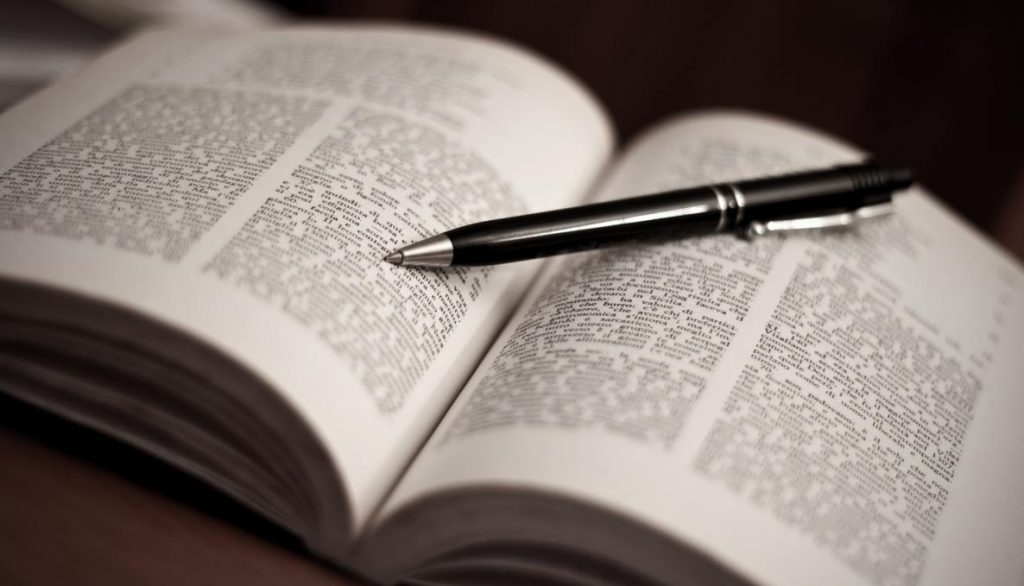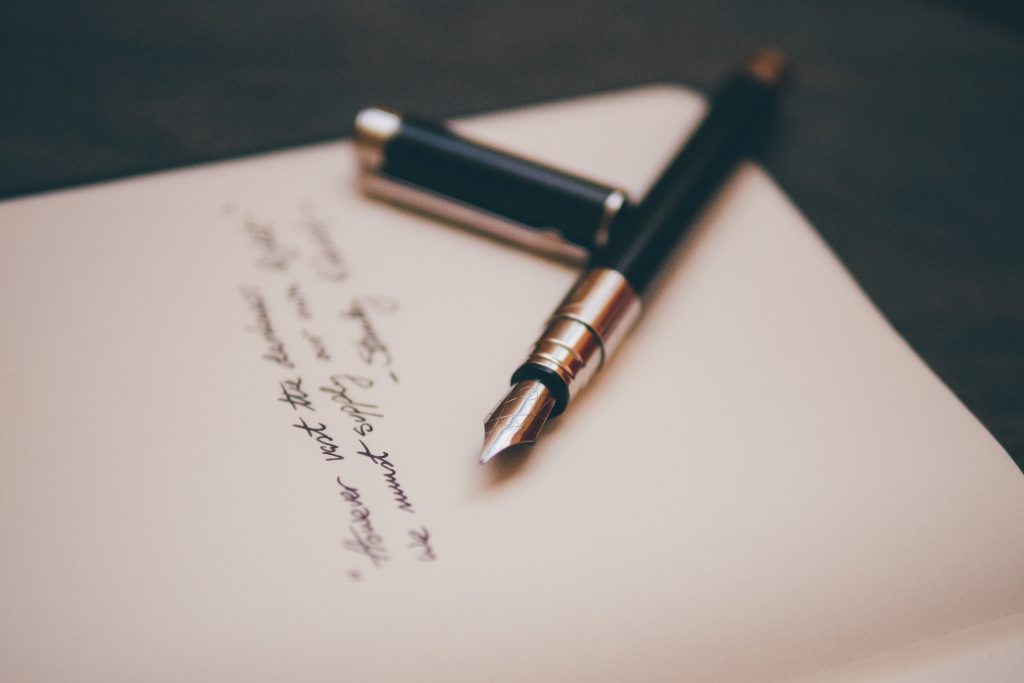1. La riforma del rito in cassazione. Premessa
La cd. Riforma Cartabia, come noto, è intervenuta, modificandolo parzialmente, ma comunque in maniera rilevante, anche sul giudizio di cassazione, in primo luogo, mediante la riformulazione del c.d. filtro in Cassazione, prevedendo un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Più in particolare, a tal fine, nei casi in cui il Giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisi uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso.
Quest’ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio.
Sotto altro profilo, è stata introdotta dal Legislatore una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile, riferita ai casi in cui il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.
Al fine di dare attuazione, anche in tale fase di impugnazione, ai criteri e principi di celerità e speditezza, che hanno caratterizzato l’intera novella, il Legislatore, inoltre, è intervenuto sui seguenti istituti:
2. Il contenuto del ricorso
In osservanza dei principi ispiratori della Riforma, più volte sopra richiamati, il Legislatore è intervenuto anche sul contenuto del ricorso (in Cassazione), prevedendo che lo stesso debba contenere «la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione».
Tale precisazione, letta in coordinato con l’attuale art. 366, comma 1, c.p.c. dedicato al contenuto del ricorso, che prevede già al n. 2) «l’esposizione sommaria dei fatti della causa» e al n. 3) «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», deve essere interpretata come rafforzativa dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti, anche in tale fase giudiziale.
Sotto altro punto di vista ed in merito al contenuto del ricorso, poiché è stato soppresso l’art. 348 ter c.p.c. a seguito del venir meno del “filtro di inammissibilità”, sono state conservate le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale articolo, volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”.
Tuttavia, tali disposizioni sono state inserite all’interno dell’art. 360 c.p.c., mediante l’aggiunta di un nuovo comma, tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero.
E’ stata aggiunta, inoltre, la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di “doppia conforme” e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo Giudice.
Sempre dal punto di vista formale, il primo comma dell’art. 366 c.p.c. elenca i requisiti richiesti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, al fine di rispettare il principio di autosufficienza, il quale, come noto, richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di legittimità di conoscere, dalla sola lettura del ricorso, la controversia ed il suo oggetto, e di valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.
In particolare, la vigente disposizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. prevede «l’esposizione sommaria dei fatti della causa», mentre nel d.lgs. tale requisito viene riformulato come «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso».
Da tale modifica emerge che il Legislatore delegato, tenendo conto che l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto funzionale alla stessa comprensione dei motivi e valutazione della loro ammissibilità e fondatezza, ha voluto porre l’accento, in maniera esplicita, sui due requisiti della chiarezza e dell’essenzialità.
Il primo requisito è riferito al modus della narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili ed univoci.
Il secondo, invece, attiene al quid e al quantum dei fatti, essendo necessario che il motivo esponga solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato, ritenendosi in ciò ribadito anche il concetto di sommarietà (ossia, per riassunto e sintesi).
Con riferimento al requisito di cui al n. 4), attualmente il ricorrente è onerato ad enunciare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis». Tale requisito risulta così riformulato: «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».
È stato, quindi, aggiunto lo specifico riferimento alla chiarezza e sinteticità anche per quanto riguarda l’esposizione dei motivi di impugnazione, che costituiscono l’unico oggetto del giudizio di cassazione, giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata.
Quanto, infine, al requisito di cui al n. 6, il testo attuale prevede «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», mentre il nuovo d.lgs. propone la seguente riformulazione: «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi».
L’art. 366 c.p.c. presenta due ulteriori innovazioni, in attuazione del principio di delega previsto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della l. n. 206 del 2021, in base al quale è necessario che nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione «il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici».
Tale principio di delega mira a rendere obbligatorio il deposito degli atti e dei documenti di parte anche nel giudizio di legittimità. Per questo motivo, è stato eliminato il secondo comma dell’art. 366 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso introduttivo (come il controricorso) non dovrà più contenere l’elezione del domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi di cui all’articolo 16 sexies del d.l. 179 del 2012.
Interessato dalla riforma è anche l’art. 369 c.p.c., dedicato al deposito del ricorso, al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti.
Al primo comma, quindi, è stato eliminato ogni riferimento al deposito «in cancelleria», trattandosi di modalità connessa al deposito analogico degli atti e dei documenti di parte.
Poi, nell’ottica della semplificazione, accelerazione e razionalizzazione del giudizio di legittimità, è stato soppresso l’ultimo comma dell’articolo 369 c.p.c., che onerava il ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della corte di Cassazione.
Sempre al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte, nonché al fine di semplificare, accelerare e razionalizzare il giudizio predetto, sono stati modificati gli artt. 370 e 371 c.p.c.. In particolare, di sicura importanza al fine della semplificazione è la modifica apportata all’art. 370 c.p.c., con la quale è stato eliminato l’obbligo della notifica del controricorso e all’art. 371 c.p.c. è stato eliminato l’obbligo della notifica del ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c. e della notifica del controricorso al ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.). Tali incombenti, infatti, non sono più necessari, tenuto conto che tutti gli atti di parte devono essere depositati telematicamente, e quindi, una volta inseriti nel fascicolo informatico, sono visibili e consultabili dalle altre parti.
Al primo comma dell’art. 370 c.p.c. è stato anche fissato in quaranta giorni il termine per il deposito del controricorso, quale termine che somma i due termini di venti giorni, rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso dall’originaria formulazione dell’art. 370 c.p.c.
Analogo termine di quaranta giorni era previsto, dall’art. 371 c.p.c., per la notifica del ricorso incidentale e tale è stato mantenuto per il deposito dello stesso.
Infine, all’art. 372 c.p.c. è stato eliminato l’obbligo di notificare alla controparte l’elenco dei documenti depositati ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
3. La trattazione del ricorso
Rilevanti modifiche apportate dalla Riforma Cartabia riguardano, anche, la fase della trattazione del ricorso per cassazione, il cui riordino viene disciplinato in primo luogo attraverso la previsione dei casi in cui la Corte procede in udienza pubblica.
Con riferimento alla pubblica udienza, infatti, l’art. 1, comma 9, lett. f), della legge delega riserva la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, «quando la questione di diritto è di particolare rilevanza».
Sicché, al fine di dare attuazione al principio di delega di cui alla lett. f), è stata riformulata la rubrica dell’art. 375 c.p.c., prevedendo «Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio» e poi è stato introdotto un nuovo primo comma, che prevede che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391 quater c.p.c..
La decisione con sentenza secondo il rito della pubblica udienza rimane, quindi, un’ipotesi residuale e riservata alle cause di alto livello qualitativo, in cui è fondamentale la funzione nomofilattica della Corte.
4. L’unificazione dei riti camerali
Tra le più importanti novità della Riforma Cartabia, vi è l’unificazione dei riti camerali, ed infatti, è prevista l’uniformità dei riti camerali disciplinati dagli artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c., cioè dei due procedimenti attualmente utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, dinanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici.
Tale unificazione è stata attuata mediante: (i) la soppressione dell’attuale sesta sezione e lo spostamento della «relativa competenza» dinanzi alle sezioni semplici; (ii) la soppressione del procedimento camerale ora utilizzato davanti alla sesta sezione, come disciplinato dall’art. 380 bis c.p.c.
In particolare, si è stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.
Poi, la parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
Quanto al P.M., rimane ferma la possibilità di sollecitare la rimessione alle sezioni unite o durante la discussione nel corso dell’udienza pubblica, ovvero – per i soli procedimenti avviati alla trattazione camerale – con le conclusioni depositate nel termine previsto dall’articolo 380 bis.
5. Le novità per l’udienza pubblica
In riferimento alle novità apportate dalla Riforma Cartabia alla disciplina delle udienze pubbliche innanzi la Corte di Cassazione, deve essere segnalata, in primo luogo, la modifica dell’art. 377, comma 2, c.p.c., con cui è stato aumentato da venti a sessanta giorni il termine che deve decorrere tra la comunicazione ai difensori delle parti e al pubblico ministero della data fissata e l’udienza medesima, al fine di realizzare un contradditorio più esteso tra le parti.
Una importante novità, che recepisce normativamente una prassi diffusa, è contenuta, inoltre, nella modifica dell’art. 378 c.p.c., che prevede la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria scritta prima dell’udienza.
Il termine per il deposito di tale memoria è stato fissato in almeno venti giorni prima dell’udienza al fine di allinearlo con l’analoga previsione contenuta nel rito camerale. Peraltro, è stato elevato a dieci giorni prima il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, anche qui al fine di allinearlo al termine di dieci giorni previsto nel rito camerale dall’art. 380 bis c.p.c.
Nel secondo comma dell’articolo in esame risulta precisato che le memorie delle parti, depositate in prossimità dell’udienza, devono essere sintetiche ed avere carattere illustrativo.
Sempre con riferimento all’udienza pubblica, l’obiettivo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, previsto dalla legge delega, ha suggerito interventi non troppo incisivi anche sull’art. 379 c.p.c., che disciplina la discussione.
Innanzitutto, è stata inserita l’espressa previsione che l’udienza pubblica si svolge sempre in presenza, così escludendosi la possibilità che l’udienza pubblica venga trattata in forma cartolare, attesa la sua particolare importanza e solennità e tenuto conto che ormai è destinata a trovare applicazione solo in un ristretto numero di casi, quando cioè la questione di diritto risulta di “particolare rilevanza”.
Le esigenze di semplificazione e speditezza hanno ispirato anche la modifica del vigente primo comma dell’art. 379 c.p.c., volto a disciplinare il contenuto della relazione tenuta dal relatore all’udienza pubblica, prevedendo semplicemente che il relatore esponga in sintesi le questioni della causa, ciò affinché la relazione sia volta a far emergere i temi della discussione orale.
Infine, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno intervenire anche sull’art. 380 c.p.c., aggiungendovi un terzo comma, nel quale si prevede che la sentenza sia depositata nel termine di novanta giorni.
6. Le novità per il rito camerale e il nuovo procedimento accelerato
Altra importante novità della Riforma Cartabia è sicuramente l’introduzione di un rito camerale cd. accelerato, per la definizione dei ricorsi che siano: (i) inammissibili; (ii) improcedibili; (iii) manifestamente infondati.
Più in particolare, il nuovo procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c. prevede che, quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il Presidente della sezione o un Consigliere da questo delegato, ove ravvisi l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, formula una sintetica proposta di definizione del giudizio, che deve essere comunicata ai difensori delle parti per la relativa valutazione.
Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Pertanto, non essendo ancora fissata la data della decisione, il Presidente o il Consigliere della sezione pronuncia decreto di estinzione.
Se, invece, la parte chiede la decisione entro il suindicato termine, la Corte procede seguendo il procedimento disciplinato dall’art. 380 bis. c.p.c. e, se il giudizio viene definito in maniera conforme alla proposta, si applica l’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Tale termine di quaranta giorni, in luogo di quello di vento originariamente previsto, viene giustificato proprio per consentire alle parti una più attenta valutazione della proposta, al fine di consentire una scelta meditata e consapevole, che tenga conto anche delle gravi conseguenze per la parte in caso di decisione conforme alla proposta.
Proprio in considerazione delle suesposte gravi conseguenze, se il ricorrente, non condividendo la proposta del Presidente, o del Consigliere da lui delegato, intende chiedere la valutazione da parte dell’intero Collegio in camera di consiglio, tale richiesta necessita di un atto di impulso processuale che coinvolga la parte personalmente.
Il principio di delega sancito dall’art. 1, comma 9, lett. e), n. 3, ha previsto che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio, il ricorso si intenda rinunciato e il Giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente, che non presenta la richiesta, dal pagamento di quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
La novità del procedimento è, dunque, rappresentata dal meccanismo della rinuncia, che non deve più essere espressa e non deve essere notificata alle controparti, ma si deduce dal comportamento processuale della parte, che non chiede, nel termine indicato, la fissazione della camera di consiglio, comportando l’estinzione del giudizio.
Sempre nell’ottica della sinteticità, si è precisato che le memorie che le parti possono depositare devono essere sintetiche ed illustrative. Infatti, mentre nel vecchio rito camerale dinanzi alla sesta sezione non era previsto l’intervento del procuratore generale, nei procedimenti in camera di consiglio (che si svolgono sempre in assenza delle parti) è prevista la possibilità per le parti e per il pubblico ministero di depositare le proprie conclusioni scritte. Tali memorie sono sempre facoltative per i procedimenti in camera di consiglio, salvo nei procedimenti per regolamento di competenza o di giurisdizione, in cui il deposito delle conclusioni scritte è necessario.
Per contro, l’intervento in udienza pubblica del procuratore generale, sia presso le sezioni unite sia presso le sezioni semplici, rimane sempre obbligatorio e può articolarsi in forma scritta (sempre eventuale, salvo nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria).
E’ stato, infine, introdotto il modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento, prevedendo che, al termine della camera di consiglio, l’ordinanza succintamente motivata debba essere immediatamente depositata, salva la possibilità per il Collegio di riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.
7. La nuova causa di revocazione
Infine, la cd. Riforma Cartabia ha previsto l’introduzione di una nuova ipotesi di revocazione dei provvedimenti resi dai Giudici italiani, ivi compresa la Corte di cassazione, qualora il contenuto del giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo.
In proposito, la delega ha stabilito i seguenti criteri direttivi:
I suddetti principi di delega si pongono in linea con i solleciti da tempo provenienti dalla Corte costituzionale, al fine di assicurare una effettiva restitutio in integrum, in caso di violazione dei diritti garantiti dalla CEDU.
In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l’art. 391 quater c.p.c., prevedendo la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.
La disposizione in esame subordina l’esperibilità del rimedio a due presupposti: (i) che la violazione accertata abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; (ii) che l’equa indennità eventualmente accordata dalla CEDU non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione.
Il secondo comma detta alcune regole procedurali, stabilendo che il ricorso per revocazione è proponibile nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea.
Inoltre, in caso di accoglimento della domanda di revocazione, viene richiamato l’art. 391 ter c.p.c., al fine di limitare la fase rescissoria dinanzi alla Corte di cassazione solo qualora la nuova decisione sia possibile senza ulteriori accertamenti di fatto. Infine, il terzo comma, in conformità alla delega, ha introdotto una previsione generale di salvezza dei diritti che i terzi, in buona fede, abbiano acquistato in base alla decisione oggetto di revocazione; i terzi tutelati, tuttavia, sono solo quelli che non abbiano partecipato al giudizio dinanzi alla CEDU.